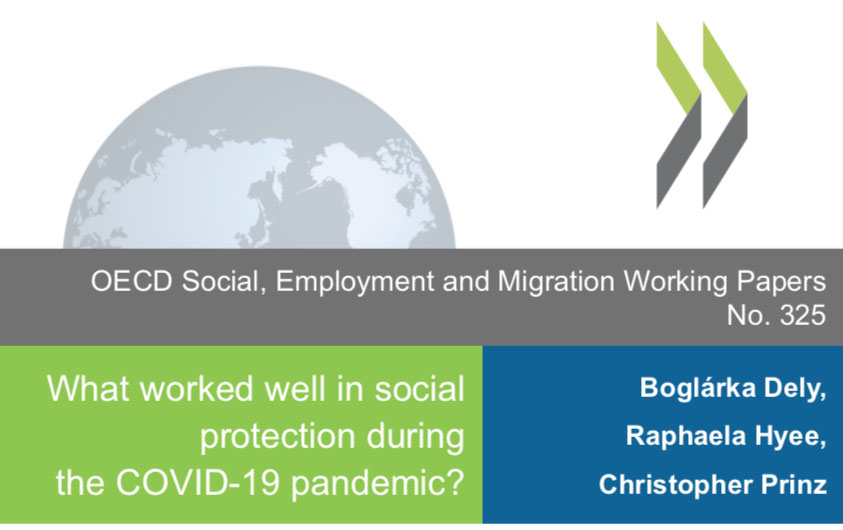Un’analisi approfondita dell’Ocse rivela come i sistemi di protezione sociale abbiano risposto con efficacia alla crisi pandemica. Le misure di sostegno al reddito, in particolare i Job Retention Schemes e l’estensione dei sussidi di disoccupazione, hanno evitato una disoccupazione di massa e arginato l’inattività lavorativa. Lo studio evidenzia anche criticità, come la debole tutela per gli autonomi, e offre spunti per rafforzare i sistemi di welfare in vista di future crisi.
Qui trovate il documento completo:
What worked wellin social protection during the COVID-19 pandemic?
La pandemia di Covid ha rappresentato una delle più gravi emergenze sanitarie e sociali dell’epoca contemporanea. Tuttavia, a cinque anni dall’inizio della crisi, una dettagliata analisi pubblicata dall’Ocse offre uno sguardo inedito su cosa abbia realmente funzionato nei sistemi di protezione sociale dei Paesi avanzati. Attraverso un’ampia rassegna di dati e valutazioni empiriche, lo studio illustra i fattori che hanno permesso di mitigare l’impatto occupazionale ed economico della crisi, proteggendo milioni di cittadini e impedendo un aumento strutturale dell’inattività lavorativa.
Un colpo senza precedenti, assorbito in modo diverso
Durante i primi mesi del 2020, le restrizioni sanitarie necessarie per contenere il virus hanno avuto un effetto drammatico sui mercati del lavoro. Secondo i dati Ocse, il calo medio delle ore lavorate ha superato il 15% nel secondo trimestre 2020. Ma il modo in cui questa crisi si è tradotta in perdita di reddito e occupazione ha variato enormemente da Paese a Paese.
I Paesi europei, dotati di solidi Job Retention Schemes (JRS), hanno assorbito il colpo soprattutto riducendo l’orario di lavoro dei dipendenti, senza interrompere i rapporti contrattuali. In alcuni casi, oltre il 90% del calo delle ore lavorate è avvenuto senza licenziamenti. In contrasto, in Paesi come Stati Uniti e Canada – che hanno puntato maggiormente sull’estensione dei sussidi di disoccupazione – la risposta si è tradotta in una più marcata perdita di posti.
Questa differenza di approccio ha influito anche sulla velocità della ripresa: grazie al mantenimento del legame lavoratore-impresa, molti Paesi europei hanno registrato un ritorno ai livelli occupazionali pre-pandemici già nel 2022.
Job Retention Schemes: la colonna portante dell’intervento europeo
Tra gli strumenti più efficaci figura senza dubbio il JRS, utilizzato in modo massiccio in tutta Europa. Questo meccanismo ha permesso alle imprese in crisi di ridurre l’orario dei lavoratori mantenendo però l’occupazione, con lo Stato a coprire parte del salario perso. In Belgio, il sistema del droit passerelle, originariamente marginale, è stato esteso fino a coprire oltre il 50% degli autonomi nel picco della crisi.
Uno studio su scala europea ha confermato che i Paesi con un uso intensivo di JRS hanno visto aumenti più contenuti dei tassi di disoccupazione e una minore incidenza della povertà. In media, il tasso di povertà è rimasto stabile al 12%, con riduzioni significative in Paesi come Canada, Cile e Stati Uniti.
Tuttavia, l’efficacia dei JRS ha risentito del loro disegno. Programmi poco selettivi, come il Paycheck Protection Program negli Stati Uniti, hanno prodotto alti costi per ciascun posto salvato (fino a 258.000 USD per anno-lavoro), con ampie quote dei fondi finiti in bonus, dividendi o utili aziendali, piuttosto che nei salari.
Disoccupazione: estensione dei sussidi sì, ma con equilibrio
La seconda linea di difesa è stata l’estensione dei sussidi di disoccupazione (UB). Trenta su trentotto Paesi OCSE hanno esteso accesso, durata o importi dei sussidi, spesso attraverso l’introduzione di misure straordinarie o semplificate. Alcuni, come Francia, Canada e Stati Uniti, hanno aumentato anche le indennità per i lavoratori discontinui o marginali.
A sorpresa, lo studio mostra che gli effetti disincentivanti dei sussidi potenziati sul ritorno al lavoro sono stati minimi. In una situazione in cui le opportunità di lavoro erano ridotte, la priorità è stata garantire sicurezza economica. Solo negli USA – dove i sussidi sono arrivati a coprire oltre il 100% dei salari precedenti per il 75% dei beneficiari – si è osservata una lieve riduzione dell’intensità di ricerca del lavoro, ma senza conseguenze gravi in termini occupazionali.
L’autonomo dimenticato: una vulnerabilità emersa con forza
La pandemia ha fatto emergere una grave lacuna nei sistemi di welfare: la protezione sociale per i lavoratori autonomi. Prima del 2020, solo 11 Paesi OCSE offrivano agli autonomi una tutela equivalente a quella dei lavoratori dipendenti. Questo ha determinato ritardi nei pagamenti, difficoltà nella verifica dei redditi e numerosi casi di sovracompensazione.
Dove sono state istituite misure specifiche – come il già citato droit passerelle in Belgio o il Self-Employment Income Support Scheme nel Regno Unito – i tassi di copertura sono stati elevati, ma con significativi problemi di targeting. In UK, ad esempio, il 77% degli autonomi ha ricevuto sostegno, contro il 30% dei dipendenti coperti dai JRS, e in molti casi i benefici sono stati superiori ai redditi consueti.
L’esperienza ha spinto molti Paesi, tra cui Italia, Portogallo, Spagna e Lussemburgo, ad avviare riforme strutturali per estendere in modo permanente la protezione sociale degli autonomi.
Disabilità: nessun effetto sistemico rilevato, per ora
Uno dei timori più rilevanti all’inizio della pandemia era che il lungo isolamento, la perdita di lavoro e gli effetti a lungo termine del Covid potessero innescare un aumento strutturale delle richieste di invalidità, segnando un’uscita definitiva dal mercato del lavoro per molti.
Secondo il rapporto Ocse, questo scenario non si è verificato fino al 2023. I dati relativi a 18 Paesi mostrano che le domande di sussidio di invalidità non sono aumentate in modo rilevante, con alcune eccezioni marginali (es. Canada e Germania). In Paesi come Austria, Regno Unito o Finlandia, le domande hanno continuato a calare o sono rimaste stabili.
Anche i casi di Long Covid che hanno portato a benefici di invalidità sono stati numericamente modesti: in Germania, nel 2023, solo l’1,6% delle nuove domande era legato a questa condizione.
Assenza per malattia e disoccupazione di lungo termine: un potenziale ritardato
Lo studio invita alla cautela. In molti Paesi, le assenze per malattia hanno registrato un picco solo nel 2022, quando i JRS erano stati ritirati e lo smart working era in regressione. Fenomeni come il burnout, l’ansia e altre problematiche di salute mentale – acuiti dalla pandemia – potrebbero in futuro tradursi in un aumento delle richieste di invalidità, soprattutto nei giovani.
Anche il numero di disoccupati di lungo periodo è aumentato inizialmente, ma è poi tornato ai livelli pre-pandemici nella maggior parte dei Paesi entro la fine del 2023. Tuttavia, in Finlandia, Polonia e Svezia, la disoccupazione di lungo termine è rimasta alta, suggerendo che alcune conseguenze più lente potrebbero ancora materializzarsi.
Il bilancio del rapporto Ocse è, tutto sommato, positivo. I sistemi di protezione sociale hanno retto. L’adozione rapida di strumenti noti (JRS), l’estensione delle indennità e l’adattamento delle strutture amministrative hanno evitato il collasso sociale e permesso una rapida ripresa.
Tuttavia, restano aperte alcune sfide strategiche:
– Estendere la copertura degli autonomi, includendoli stabilmente nei sistemi assicurativi.
– Migliorare la tempestività dei pagamenti in futuro, costruendo canali predefiniti per le emergenze.
– Rafforzare la componente preventiva del welfare, puntando su benessere psicologico, salute sul lavoro e riconversione professionale.
– Monitorare attentamente le disabilità legate a stress e burnout, soprattutto nei settori della sanità e dell’istruzione.
La pandemia ha agito da stress test per i sistemi di welfare. Ora tocca ai decisori politici consolidare i progressi e correggere le fragilità emerse, per garantire una protezione sociale più resiliente, inclusiva e pronta alle crisi future.